Da “L’Avocatt in bicicletta, il romanzo di 50 anni del ciclismo italiano nel racconto di Eberardo Pavesi” di Gianni Brera

LA XX SETTEMBRE DEL 1905 DI PAVESI
[…]
Sfuma la Milano-Parigi E andiamo per tramagli da paese. È un dolce settembre. Per sagre E mercati strabiliamo i villani. Dopo la corsa gareggiamo a Strippare. Albini si fa morose ad ogni uscita. II Campo di Marte è quasi deserto, il Granida sta avvelenando gli ultimi soldati e già prepara la padella dei “peri corti”. Gerbi e Cuniolo sono tornati a casa. Sta lentamente morendo l’estate.

Da Cava Manara ci giunge l’invito d’un progressista che si vuol distinguere. Basta corsa nei sacchi e salto dell’oca: la sagra 900 si fa sui pedali! Ci andiamo in venti, non meno, e troviamo “Baslot’ Rossignoli e Rossi di Pavia, Capenari di Pieve Porto Morone. La corsa è in circuito su strade comunali. In realtà ignobili carrarecce. A due chilometri dall’arrivo, un carro di fieno. Il gruppo si ingolfa sul ciglio, ma un fittabile che ci pedala incontro prende tale spavento che molla brancicando il manubrio e con un urlo ci vien fra le ruote. Batte la nuca su una pedivella, sangue gli esce dalle orecchie, sviene. Noi tutti ci si ferma a soccorrerlo. Pochi minuti d’agonia e rimane stecchito.

E’ il primo caso del genere e ci viene sgomento. Non osiamo proseguire. Come colpevoli tagliamo strada e torniamo a Milano sui nostri catorci malconci. Anche in bicicletta, scopriamo, si può morire!
Resto più giorni con il terrore che vengano a prelevarmi. Non vado in ufficio, sono in ferie. Una mattina sto sulla soglia a leggere allorché Albini mi chiama dalla Strada. Guida una comitiva di quattro o cinque. Vanno a Roma. Perché, propone Albini, non lo seguo? La storia di Cava Manara non è finita. Conviene cambiar aria. A Roma si corre la XX Settembre: Roma-Napoli e ritorno. Strade impossibili, gente dell’altro mondo, e vincono sempre i [meridionali]. Ma lui, Albini, l’anno innanzi ha fatto secondo alla primissima esperienza: Galadini l’aveva battuto per sola pratica dei luoghi. Quest’anno sarà diverso: ne è sicuro…
Chiamo il vecchio, che ciancica un mozzicone di matita sul libro dei conti. Gli spiego tutto.
«Va’ pure» dice «ma non a correre. Va’ a goderti le ferie a Roma. Soldi ne hai in tasca? Se hai quelli, il tempo non ti manca.»
«Allora paga da bere e preparati» propone con vociaccia sgarbata un amico di Albini.
«Prepararmi?» io stupisco. «E per che cosa?»
Ho una maglietta verde a mezze maniche, le bretelle nuove sopra, un berretto in ottimo Stato, un bel paio di calzoni alla zuava. Anche la Rudge è in ordine. Non resta che andare. Mi avvolgo due gomme di scorta al collo e via. Ci alleniamo sgrugnando allegri per Vigentina.

A Pavia troviamo Rossi in piazza Castello. Fa il prestinaio: s’è appena alzato dal sonno. Gioca alla lippa, il baseball dei lombardi. Albini cerca proseliti e invita anche lui. Rossi è un po‘ caposcarico, suppongo. Non ci pensa più di un attimo. Butta il bastone e corre nel sottoscala a prendere la macchina:
«Vengo anch’io» dice. «sono disallenato, ma farò gambe e fiato in viaggio.»
A Montebello è buio e i carabinieri ci fermano perché non abbiamo Fanale. Albini dà il nome falso: tutti quanti ne inventano uno lì per lì. Si può farlo tranquillamente: passaporti, carte d’identità verranno solo il giorno in cui l’avremo fatto in troppi.

Dormiamo al Bracco (sotto un portico), filiamo di buon passo verso il Sud. Albini a Pisa dilata le nari come uno stallone vedovo. «So io dov’è il posto» dice. Svicoliamo circospetti verso l’Arno. Albini fa da guida e per poco non nitrisce infilando una scaletta umida e sentinosa: vede una porta socchiusa e senza bussare entra. Ragazze ve n’è molte, sedute in giro, ma cuciono.
«O che vogliono!» esclama una stupita. Albini non ha ancora potuto dir buongiorno che irrompe un omarino brandendo minaccioso il ferro da stiro.
«Oh Madonna!» geme interdetto Albini: si scansa e arretrando ci spintona fuori: ridendo a crepapelle ruzzola per le scale mentre il maestro sartore, inferocita, ci grida roventi improperi dal pianerottolo.
«Dopo un fatto simile» bercia Albini, «potrei tornare tranquillo che non vinco: eppure mi pareva su quella scala.»
Pedalando in comitiva scopriamo l’Italia ed io, se debbo dirlo, ho un po’ vergogna. La ganga non è precisamente raccomandabile. Verso Grosseto, mentre un poveraccio di barcaiolo traghetta gli ultimi, i primi a passare fiume gli spogliano l’orto. Poi filan via facendosi beffe di lui.

Maledizioni, però, quel poveraccio deve avergliene mandate tante. A Orbetello prendiamo un bagno nel lago e per poco non sprofondiamo nel fango. Per fortuna si fa catena e il più prudente, rimasto a riva, ci trae in salvo.
Altra scoperta carina: il solo ad avere qualche soldo sono io. Albini e soci hanno finito tutto. Rossi è partito a zero. Dico: d’accordo, sono disposto a dividere. Ma trenta lire non possono bastare.
A Roma arriviamo da ladri. Fradici, insudiciati. E con molta fame. Il fascino della città è ancora sui libri che nessuno di noi ha letto. Ci sta il Papa, ecco: E il Re da qualche anno. Dicessi altro, sarebbe impressione non vera. E’ tardo pomeriggio e ci opprime l’idea di dormire con le zanzare. Per fortuna incocciamo Gaioni, corista della Scala. Riconoscere dei lombardi, da queste parti, dev’essere facile assai. Gaioni si commuove al suo dialetto. Ci offre da bere, è gentile, si fa in quattro. Ma quando Albini gli si avventa in flèche para di prima: sciabolate ne deve già tirar lui!




«Volete un consiglio?» dice. «Incominciate a risparmiare sull’alloggio.»
«Mancano due giorni alla gara: non pretenderai che dormiamo in terra!»
«Non questo» dice Gaioni, «ma consentitemi di indicarvi un posticino fuori le mura. Siete meccanizzati, che ci vuole per andare in campagna? A Valmontone conosco un oste…»
A Valmontone ci ammucchiamo in un granaio sotto i tetti.
«E il comodo?» io domando.
«Che cosa?» ruggisce il padrone allibendo. «Ah, per i vostri bisogni? Ecco qua» e spalanca una finestra che dà sull’andito.
Torniamo in gran fretta a Roma il mattino. Gaioni ci attende (cardanello e giannetta) all’Esedra. La nostra fame è da corridori. Il cielo di Roma sfrigola arrosti immortali. Le zaffate dei ristoranti inciucchiscono.
«Sapete che facciamo?» dice Gaioni, «mettiamo insieme i ghelli e andiamo a via Nazionale: il padrone del “Marinese” è uno sportivo.»
«Cos’è il “Marinese”?» domanda Albini dilatando le nari, «ci sono belle ragazze?»
Se non la smette lo strozziamo subito. Il “Marinese” è un ristorante alla moda.
«Questi qui» spiega Gaioni al proprietario, «sono campioni milanesi venuti a vincere la XX Settembre. Dategli un bel piatto di fettuccine se non volete che vi si tacci di antisportivo. Un corridore che non mangia non può rendere.»
Il padrone capisce e ordina una montagna di pasta per noi. Gli avventori – gente elegante – stupiscono a vederci. Succhiamo le fettuccine come fossero brodo lungo. Al contrario, Gaioni fa il distinto. Lui, che diamine, è un artista.
Viene poi uno sminfarolo e attacca con la chitarra.
«Ohei, Caruso, fatti sentire» bofonchia Albini ingozzandosi. Piccato, Gaioni vorrebbe schermirsi.
«E dàlli!» insiste Albini, smerigliando il piatto con una crosta di pane. «Se tu canti io giro e faccio la cerca.»
Molti avventori hanno sentito, e danno in grasse risate.
«Non crederai che abbia paura», si inalbera Gaioni. Inghiotte con sussiego l’ultimo boccone, si schiarisce la voce: ehm, ehm, tossicchia guardando il soffitto. «Attacca pure» dice poi al chitarrista, «canto Di quella pira, la sai?»
Sentir cantare, con fame, è come avere una rana viva nelle budella. Ma l’arte ha le sue leggi e Gaioni raggiunge lo scopo: gli stessi avventori invitano Albini vergognoso a iniziare la cerca. Piovono soldoni di rame nel berrettuccio infarinato di Rossi. Il padrone autorizza allora una seconda portata di pasta. Una collina. E la spianiamo facile.
Trovato l’inghippo, vivere due giorni a quel modo è uno scherzo. Dormiamo in Trastevere, costringiamo Gaioni a cantare su tutti gli angoli. E Albini fa la cerca con tale un garbo che la gente si affretta a pagare la decima per non dover troppo reggerne lo sguardo.
Intanto Roma si appresta al grande giorno. Il «Messaggero» e la «Tribuna» presentano la XX Settembre come la corsa dell’anno, la classica, la stupenda Roma-Napoli-Roma. E il pronostico poco poco ci ignora. «Gli altitaliani» scrivono i giornalisti, «non sanno correre sulle nostre strade. Non hanno mai vinto e nemmeno quest’anno possiamo pensare che la supremazia dei nostri migliori debba finire.»
I loro migliori erano tutti garzoni ciclisti. Tracagnotti dai capelli corvini e di lingua pronta. Uno si chiamava Grammel e vinse la Gran Fondo. Ricordo che finì tra le corna d’un bue, in una corsa.

Per la XX Settembre partimmo in sessanta. A noi ci facevano moine come a stranieri, gente d’un altro mondo, e per niente temibile. Ci chiamassimo Gerbi o Cuniolo, poco importava. L’Italia era molto più lunga, in quegli anni.
Cuniolo montava la Rudge come me e il rappresentante di Roma ci offrì assistenza da una “Temperino” che era (se non erro) un’automobile utilitaria di pochissimi pregi. Alla vigilia Veladini aveva telefonato al rappresentante di Roma promettendo per noi cinquecento lire della Casa e seicento delle gomme Clinker se avessimo vinto. I premi degli organizzatori, poi, erano ingenti.
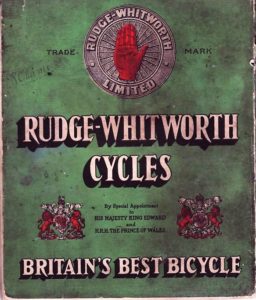
ll percorso non era identico nei due sensi. A Napoli si scendeva per Cassino, a Roma si tornava per Terracina. Partimmo alle atto da piazza del Popolo e andammo per Colonna e Frosinone. La Strada era lastricata al modo di Romolo e Remo, con polvere molta e sassi da stroncare. La “Temperino” bolsicchiava asfittica dietro la poderosa Bianchi di Gatti e Tommaselli.

Noi non prendemmo viveri fidando nella Rudge di Roma. E ce ne pentimmo assai. Dei quattrocentosessanta chilometri, la “Temperino” al più ne avrà fatti dodici. Per fortuna Albini montava una Turkheimer e qualche soldo, per il pane, l’aveva rimediato. Dividemmo quello a mezzodì, moccolando. Cuniolo si ritirò quasi subito. Come era polvere in coda, pensammo di rimontare. E lo facemmo con tale impegno da trovarci poi soli a guidare la corsa, Albini, Rossi ed io. Tre lombardi.




Rossi era poco allenato e verso Cassino lo piantammo. Intorbidì l’acqua d’una fontana e ci indignammo con lui per una scusa. Albini saltò in sella e disse: «Io vado. Se siete buoni seguitemi pure».
Così fummo noi due soli che già imbruniva. La Bianchi di Tommaselli era lontana con i suoi. Le campane dell’Ave ci inseguivano petulanti. I contadini, sulla soglia, mangiavano cena. Quando, affamati, scendemmo a chiedere qualcosa, ci diedero da pulire le pignatte. Che noi pulimmo. E tutta la corsa XX Settembre eravamo noi due soli nell’Agro: noi per la poca gente stranita dalla malaria, noi per i bufali neri accosciati nel brago ai margini della strada, noi per il lupo che dentro ci ululava mordendo le carni, per la nostra maledetta fame di poveri, per le gambe indurite che dolevano.

A Napoli soltanto udimmo applausi. Laggiù veramente sapevano che noi si correva. Al rifornimento ci stesero di forza su un pancone:
«Sta’ a vedè» sussurrò Albini, «che adesso ci fregano la bicicletta.» Invece, di gran lena, ci massaggiarono, e altri intanto ci offrivano cosce di pollo, ci ingozzavano di roba così buona da morirne beati. Partìmmo come schioppi ma quasi alla cieca: «Andate in su,» ci dissero, «sempre diritto all’insù. Non potete sbagliare».
«E se invece» mugugnava Albini, «fosse questa la strada che porta in Sicilia?» Ci fermammo a domandare più volte: «in su, in su» rispondevano tutti.



Una tetra angoscia ci andava abbacchiando. Nuvole paurose galoppavano basso nel cielo. Buio pesto, vento, brividi. E lo schianto d’un fulmine ogni poco, il rumoreggiare vasto dei tuoni. Sono questi i momenti in cui uno vorrebbe gridare, leticare, dar fuori da matto, strangolare uno pur di sentirlo vivo con sé; sono i momenti in cui tornano a casa anche i ladri, non i corridori. L’uomo ha nel sangue il ricordo della tana. A quest’ora, suonagli una campana e si mette in ginocchio; ma non se è corridore. Stramaledetto il giorno che ho visto Albini ed ho avuto paura. Stramaledetta l’ora, il ciclismo e la XX Settembre. Mio padre mi ringhia dietro improperi e, per la primissima volta da che vivo, forse gli do ragione.
Tutto questo io vado filando in me stesso mentre sgrugno. E un’ultima ventata m’acceca. Esplode un tuono, schiatta un lampo fra i neri ulivi ai margini. Uno scroscio di gelida pioggia c’investe di lato.
«Allez allez!» dice Albini ingobbendosi. «Qui se si sfanga un po’ siamo fottuti. È proprio argilla, questa terra da pipe.»
«Senti Albini» dico, «comunque vada a finire, mettiamoci d’accordo. Se uno sa che divide lavora meglio.»
Non ho paura, com’è vero Dio. Voglio solo sentirmi, ecco, voglio sentire lui. Ma Albini non capisce:
«Gh’è temp, gh’è temp» nicchia a pararmi via.
Sotto la pioggia, due fantasmi luridi, e ammollati per giunta, ma cattivi: io per l’amor proprio offeso, e il dispetto di essermi abbassato; lui per la brama di vincere, la decisione, l’avidità. Ed ecco, un gran moccolo pieno d’ira gli si spegne in un gemito:
«Fermati, Eberardo» dice umiliato (e incerto) il gaglioffo, «fermati che ho una gomma a terra.»
Lì per lì mi vien voglia di insultarlo. Brutto Vigliacco, dire, adesso mi vorresti come socio! Sto zitto, invece, perché non conosco la strada e non ci vedo. Meglio restare in due.
Tremula il fanaletto d’un carro alla prima svolta. Nel suo fioco alone fuffigniamo a cambiare la camera d’aria. Niente. Nella valvola si è fusa la cioccolata di scorta. Impossibile adesso gonfiare.
Albini piange di rabbia.
«Mettiamo del fieno nel copertone» dico, «servirà per arrivare al primo Paese.»
Mentre ci avviamo, il rumore lontano d’una macchina. Le sciabolate dei fari nel diluvio. È la Bianchi di Tommaselli che segue Jacobini, il gran favorito della stampa romana.
«Visto che non hai accettato di fare corsa insieme» incomincio a dire con qualche impaccio. Albini non trova di meglio che maledirmi di tutto cuore. E io ho l’animo sgombro.
«Ehi, Jacobini» dico saltandogli a ruota.
«C’è altri avanti?» lui mi domanda con voce da brividi.
«Nessuno.»
«E tu chi sei?» mi grida Tommaselli dalla macchina.
«Sont el Pavesi. »
«Allora possiamo fermarci un poco» implora Jacobìni senza fare misteri sul suo stato.
«Sigura» Gatti ridacchia, «fermiamoci pure che quello buono buono ci aspetta!»
«Oh» dico io, «posso anche fermarmi se vi piace: naturalmente mi date da mangiare.»
«Ma certo» Jacobini dice, «te va lo zabajone? Ce l’avemo caldo caldo nel tèrmosse.»
A Itri ci infiliamo in un portone. Diluvia sempre, a raffiche gelate. Mi porgono un bicchiere di zabaione:
«Prego, a voi» dico con il migliore garbo possibile.
«Teme che lo avveleniamo» ruggisce Tommaselli scrollando le spalle.
Jacobini barbella ingollando cibo. Gatti gli sfila la maglia, l’aiuta a indossarne una asciutta. Io prego un ragazzotto di darmi la sua, benché stracciata. Gli lascerei quella che ho indosso, bagnata, ma seminuova. Quegli accetta, ma come mi viene accanto mi sussurra di andare subito: Conti della Bianchi è appena arrivato e Tommaselli gli ha ingiunto di proseguire solo, mentre Jacobini rimane ad attardarmi. Bestemmio, contro il mio solito, nell’inforcare la macchina.
«Brutti imbroglioni» grido.
Arriva in quella Modesti, romano, che ha pure la Rudge: Jacobini rifocillato si mette alla nostra ruota.



«Lo stacco subito» urlo indignato. E non è gran fatica. Il romano, esausto, non si regge. Modesti al contrario è un utile compagno. Perciò quando fora una gomma l’aiuto a cambiare. Su Terracina arriviamo a rompicollo. Da lontano scorgiamo il fanale rosso del controllo e firma. Per la fretta non vedo il gradino del marciapiede e ruzzolo sotto la tavola della giuria, ma illeso.
ll registro del controllo è ancora vergine. «Non è passato Conti?» domando incredulo.
«Nessuno!» mi si risponde. «Nemmeno la macchina della Bianchi?»
«Nemmeno.» E mentre io perplesso mi consiglio con Modesti, uno dei presenti affaccia l’ipotesi che Conti abbia sbagliato strada, che quel rumore di macchina che si è sentito poc’anzi sia appunto quello della Bianchi lanciata alla ricerca:
«Da quella parte faranno il bagno di mare» ride un giudice, spietato.
Ad ogni buon conto non sto a perdere tempo.





Finisce l’acquivento e spunta la luna. La “fettuccia” alberata è uno spettrale tunnel rigato di ombre. Buona che la Rudge sembra una bicicletta da bersagliere, i raggi a campana, fortissimi. Ben presto ho l’impressione di pedalare su dei quadrati di gomma. Scambio talvolta per ombre d’alberi i tronchi abbattuti dalla bufera. Ruzzolo a terra, trafelato, ansante. Ogni parte di me dolora, ma la stizza che ho dentro è buon energetico.


A Cisterna, ancora nubi, folgori, vento. Piove. L’alba è livida e incerta. Offrono caffelatte e nemmeno di Modesti mi fido, non lascio la bicicletta fuori del caffè. Allora un giovanotto mi porge la scodella.
«Vuoi un consiglio, Pavesi?» quegli dice (lo riconosco per uno dei due Mancinelli, corridore ciclista e pittore) «squaglia solo. Modesti non può seguirti se fili. Ma è di qui ed ha molti amici. Possono farti uno scherzo.»
«Grazie», dico. E non aspetto oltre. Modesti mi arriva a ruota e rumina in silenzio i suoi pensieri. Non mi propone di dividere, sta gomma a gomma e lascia che io sgrugni.
Sotto la pioggia, il dosso di Velletri: Modesti arranca sfiatato e io lo lascio.
«A’ Pave’!» lo sento gridare. Ma non mi volgo. L’idea di vincere mi esalta a tal punto che non m’accorgo di aver le mani rotte, i polsi slogati, gli occhi che bruciano. Piove. Annodo le cocche del fazzoletto e mi copro alla meglio la testa in quel modo. Gli ultimi chilometri sono un calvario, ma delizioso: non pedalo, cavalco. La Rudge è un pony immortale.
E quella, buona Madonna, è Roma!





Arrivassi in Milano a quest’ora di mattina, la vedrei cinerognola nella lieve foschia di primo autunno. Roma è invece d’un soffuso color rosa sui colli, d’un tenue violetto in piano: e il Cupolone è un trono dorato su cui mi penso degno di sedere. Provate a vincere una corsa di quattrocentosessanta chilometri, in “terre sconosciute”, dopo ventiquattr’ore di pedalate, e l’esaltazione sarà tale da farvi pensare (e magari dire) ben altre sciocchezze.
lo guardo con ebete sorriso il rappresentante della Rudge che mi aspetta ai Cessati Spiriti con la più impaziente e nervosa delle “Temperino”. «Benedetto! Benedetto!» quello mi grida e mi mostra salami, caciocavalli, trecce di pane fresco, grappoli d’uva dorata. Neanche fosse un uomo di Barbariccia, ed io dannato al girone dei golosi.
C’è un’osteria, ai Cessati Spiriti: mi approntano un mastello d’acqua tiepida: mi ci tuffo sbuffando come una foca, e un dolce tepore m’invade tutto: la stanchezza medesima è un po’ del mio nirvana, di questa mia becera indifferenza che è forse il primo stadio della compiuta felicità.
Nel mastello, i resti di Eberardo Pavesi non sono che l’accidente della XX Settembre; la sostanza è altrove, e nemmeno nei premi: è nella sorpresa di mio padre burbero ma felice, nell’emozione di mia madre, nel tifo (parola ignorata ancora, ma sentimento già vivo) di tutti gli amici miei di Porta Romana.
E non parlatemi di Roma antica, non parlatemi di eroi.
Arriva Modesti, dimenando penosamente il testone, venti minuti dopo. Io sono in corte e già mi vanno asciugando fuor dal mastello fumante.
«I vestiti, i vestiti!» urla il rappresentante della Rudge.
Già, i miei panni. Li guardo a terra, miseramente ammucchiati, con la stessa rassegnata pena e il ribrezzo con cui si può osservare una tenia da poco espulsa. Il moccichino fradicio annodato alle quattro cocche, la maglietta verdolina, stinta e piena di arianne fangose, le bretelle ammollate e deformi, i calzoncini che paiono scaglie di torba. Le scarpe disfatte e gialle di mota.
II signor rappresentante si volge intorno smarrito: «Datemi un lenzuolo!» grida. Glielo portano in fretta, mi ci avvolge (e io come fuori di me lo lascio fare), mi mette all’impiedi sulla ineffabile “Temperino” e via, uno scaracchio, qualche sussulto, ci allontaniamo verso il centro in un subisso di battimani. lo debbo scmbrare Silla giovane sul cocchio. E conquistiamo la Città Eterna.
Saliamo lo scalone dei Grandi Magazzini (Fratelli Bocconi) e la gente si ferma a guardare stranita.
«Ha vinto, ha vinto» urla il signor rappresentante, «ora lo porto a vestirsi di nuovo: ha tutto consumato nella corsa: è Pavesi, il campione della Rudge Whitworth.»
Qualche altro battimani lo rimedio a quel modo, nudo come un verme sotto il lenzuolo d’una piazzemezza.
Mi fanno elegante come non sono stato mai. E appena torno uomo sulla terra mi accorgo di me, del mio catalettico sonno. «Ora ti porto a letto» dice il signor rappresentante, «nel mio letto.»
La padrona di casa è stupenda. Non dimenticherò mai i suoi occhi e la sua voce, i suoi capelli neri. Quella è per me, semplicemente, la fata del sonno.
La quale mi sveglia poco dopo mentre sto ridicolizzando in volata le più elette falangi del ciclismo mondiale: Albini, quarto arrivato, viene per un prestito. Lui, Rossi e Massironi non hanno una lira e debbono tornare. Chiedo cento lire d’acconto agli ospiti: il signor rappresentante, che è appena tornato dal negozio dove ha esposto la Rudge vittoriosa, non ha difficoltà ad anticiparmi quella ragguardevole somma. Allora Albini, magnetizzato, corre fuori agitando il fogliaccio come fosse la magna charta del suo mondo nuovo. Staranno tre giorni a fare strippate romane: poi con sole trenta lire si avvieranno mogi a Settentrione: troveranno un cargo a Civitavecchia, s’accorderanno di andare a Genova con quello: dieci lire a testa, un piatto di minestra a mezzogiorno e sera: tre giorni di viaggio col tempo buono. E aiuteranno i marinai.
Io torno in treno. Porto con me una statua di Morot acquistata dal Re all’Esposizione (valore duemila lire), un piatto d’argento messo in palio al traguardo di Napoli, medaglie d’oro del Re e dei vari Ministeri: cinquecento lire della Rudge e seicento delle gomme. Sono decisamente on scior e mio padre, che ha letto soddisfattissimo dieci righe del «Corriere» interamente dedicate alla XX Settembre, mi consiglia alla semplice di non sciupare il denaro vinto «a quel modo»: «Non farmi pensare» dice, «che la farina del diavolo va in crusca.»
Rispondo che con quei soldi avrei campato in attesa di vincerne altri; e che lascio l’impiego se lui vuole. «Per fare il corridore di professione?» il vecchio mi domanda allibito.
«Sento che potrò guadagnarmi da vivere» dico. «E appena il principale mi trova un sostituto, lascio la scrivania, la macchina per scrivere americana e le mezze maniche.»
È il novembre dell’anno 1905: normale che ricordi questa data.
[…]

